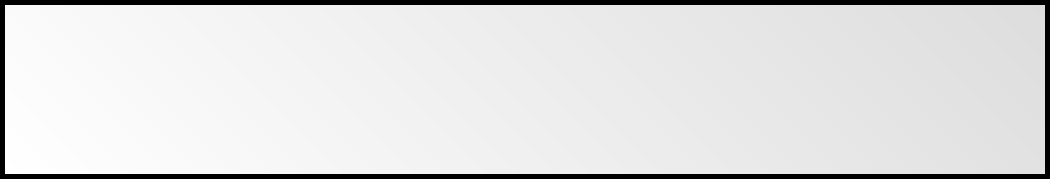Il nome del figlio
IL NOME del FIGLO – una recensione di Sabina Incardona
Dopo sette anni di assenza Francesca Archibugi torna alla regia: IL NOME del FIGLIO, tratto dalla pièce “Le prénom di Matthieu Delaporte e Alexandre de la Patellière”, già portata sul grande schermo da loro stessi con Cena tra amici (2012). Non è però, non è la solita commedia scopiazzata (male) dai “cugini” d’oltralpe.
Gli sceneggiatori Archibugi e Francesco Piccolo hanno lavorato per adattare, ridefinire, ricalibrare il copione francese alle nostre latitudini, in primis quelle capitoline: Parioli, Pigneto, Casal Palocco, dimmi dove abiti e ti dirò chi sei. A Roma come mai altrove.
La cena che si svolge al Pigneto a casa di Betta (Valeria Golino), insegnante sposata con Sandro (Luigi Lo Cascio), serioso scrittore di poca fama e professore universitario precario (ma “twittaro” a tempo pieno) entrambi genitori di due bambini diseducati e viziati dai nomi impensabili di Scintilla e Pos, vede come invitati il fratello di lei Paolo (Alessandro Gassman) agente immobiliare con la battuta e lo scherzo facili, la sua giovane moglie mastica chewing-gum di periferia Stefania (Micaela Ramazzotti) e l’amico d’infanzia musicista spiantato Claudio (Rocco Papaleo). Questo pacato quadretto borghese e familiare si trasformerà improvvisamente in un vero e proprio campo di battaglia.
La miccia, attorno alla quale si accenderà la vicenda, viene accesa da Paolo che si prende gioco di loro (professori e musicisti sinistrorsi) rivelando il presunto nome che lui assieme alla sua compagna avrebbero deciso per il figlio nascituro. Il nome, Benito, è il pungolo che fa scoppiare una tragica lite tra i convitati, che porterà alla rivelazione di segreti che potrebbero compromettere la loro pacifica quanto finta fratellanza.
Attento spaccato antropologico del nostro Paese e del suo attuale tessuto sociale e politico, Il nome del figlio riesce a conferire al “gruppo di famiglia in un interno” la pregnanza simbolica di tutta quell’inconsistenza propria di certa buona borghesia autoproclamatasi “illuminata”, le cui fondamenta poggiano sul velleitarismo e l’ipocrisia, ambedue appannaggio della gente che “dà buoni consigli quando non può più dare il cattivo esempio”. Trattasi di quanti si appellano al passato non come opportuno stimolo per dare vita ad un nuovo domani ma come un retaggio esistenziale elevato alla portata propria di un dogma imprescindibile.
Il tutto per conferire un qualche significato alle loro esistenze, una giustificazione ai loro fallimenti, ma senza manifestare interesse alcuno per i propri simili, sempre visti, ove di idee diverse, come un nemico da abbattere e non col quale confrontarsi.
A prendere in mano la situazione e a capovolgerla inaspettatamente saranno la due donne: la finora dimessa Golino/Betta, ma soprattutto una Ramazzotti/Stefania da premio e applauso e onorificenze multiple. Stefania sì, la scrittrice senza talento e dal marcato accento di periferia romana, consapevole ed orgogliosa tanto dei propri limiti che delle proprie capacità, espresse con disarmante naturalezza e fierezza nell’affermare le proprie origini e considerarle non come un limite, bensì uno stimolo a progredire e guardare con inedita speranza al futuro, conscia di “prendere qualcosa dalla vita di ogni giorno senza trama e senza finale”, come recita citando Cechov la sua voce fuori campo verso la fine del film quando assistiamo al parto (in presa diretta, vero) della donna. Una femmina. “Speriamo che sia femmina”.
Un film da vedere una boccata d’aria nel spesso asfittico panorama del “commedificio” italiano.