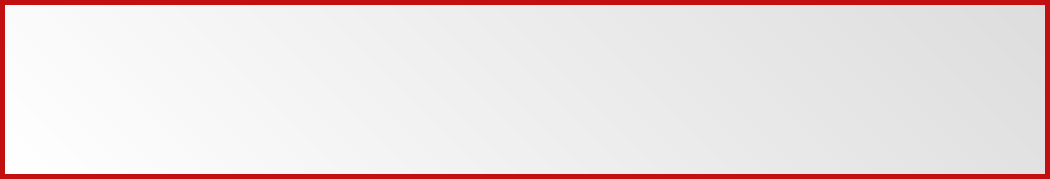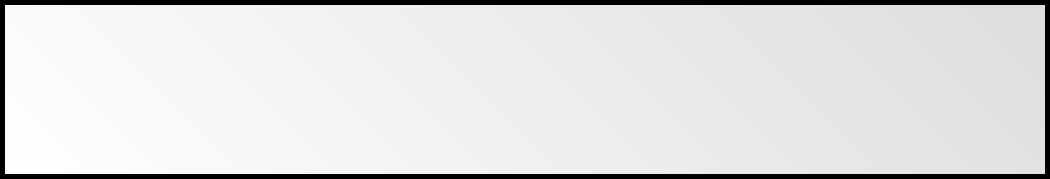IMMIGRAZIONE, serve un modello italiano
A. Nell’Enciclica Caritas in Veritate (al n. 62) Benedetto XVI ricorda che la questione della immigrazione pone “sfide drammatiche”, non tollera soluzioni sbrigative e presenta una notevole complessità di gestione; quindi fornisce tre indicazioni:
1. anzitutto richiama l’attenzione sui “diritti delle persone e delle famiglie emigrate”; ciò vuol dire che il migrante va trattato come una persona e non come una merce;
2. contestualmente ricorda la necessità di tutelare i diritti “delle società di approdo degli stessi emigrati”, senza limitare tali diritti alla sola sicurezza, ma estendendoli alla identità e alla integrità nazionale;
3. infine, richiama i diritti delle società di partenza degli emigrati, perché non siano depauperate delle risorse necessarie per lo sviluppo. Questo avendo come obiettivo ultimo “che non ci sia più bisogno di emigrare, perché ci sono in Patria posti di lavoro sufficienti, un tessuto sociale sufficiente” (intervista del Pontefice durante il volo per gli USA, 15 aprile 2008).
Due differenti posizioni violano questi principi: la xenofobia nega il primo, sia nella sua versione rozza di chi ritiene lo straniero per definizione un essere inferiore, sia in quella meno esplicita di chi sfrutta l’immigrato o facendolo lavorare in nero, o comunque remunerandolo di meno rispetto agli altri lavoratori, o utilizzandolo per manovalanza criminale. È ovvio che solo il rispetto integrale della persona, qualunque sia la lingua, l’etnia, la provenienza, l’età, costituisce l’antidoto a ogniintentio discriminatoria. Il secondo e il terzo principio sono avversati da quell’orientamento ideologico che il politologo francese Pierre-André Taguieff definisce immigrazionismo; secondo tale posizione l’immigrazione è sempre culturalmente buona ed economicamente vantaggiosa, e chi osa manifestare dubbi in proposito è immediatamente bollato come xenofobo, se non proprio razzista. Non è detto che la xenofobia sia sempre “di destra”: ci sono fasce della sinistra, soprattutto nel mondo sindacale, la cui ostilità per la concorrenza degli immigrati sul mercato del lavoro talora sconfina nella xenofobia. Né è detto che l’immigrazionismo sia sempre “di sinistra”, come informano le cronache quotidiane, anche in Italia. Certo, l’immigrazionista “di destra” è convinto che se l’immigrato viola la legge va sanzionato; ma il quesito da porsi non riguarda il rispetto del limite posto dalla norma penale.
Il quesito da porsi è più profondo e più impegnativo: un immigrato che non fa il terrorista né spaccia droga, ma vive e pensa nel nostro Paese secondo principi contrastanti con quelli che sono alla base della nostra civiltà, è o non è un problema? Rimuovere il problema fa aumentare l’entità dello stesso e fa crescere il rischio che la doverosa contrapposizione alla xenofobia degeneri nel relativismo culturale: cioè in quell’atteggiamento per il quale chiunque arrivi in Italia può – in nome del multiculturalismo – comportarsi come meglio crede, col solo remoto limite dell’ordine pubblico. E’ una posizione inaccettabile: le culture vanno giudicate in base alla possibilità che esse hanno di difendere integralmente i diritti della persona e il bene comune; ad esempio, una cultura fondata sul rispetto della donna non può ritenersi equivalente a una cultura che invece lo nega, permettendo di fatto la poligamia o l’esercizio di una giurisdizione domestica che viola la più elementare dignità della persona.
B. L’Italia è una Nazione che, rispetto ad altri partner europei, Francia e Regno Unito in testa, affronta la questione immigrazione da un tempo relativamente recente: appena vent’anni. Per questo, dopo aver superato una serie di emergenze (da ultima, quella degli sbarchi), oggi essa è in condizione di giocare la partita dell’integrazione puntando alla elaborazione di un proprio “modello”, che faccia tesoro delle esperienze degli altri Paesi, e che tenga conto della propria identità. Scopo di questo convegno è offrire spunti di riflessione, non soltanto teorici, in tale direzione, muovendo attraverso differenti – ma non contrastanti – sensibilità di impostazione culturale e di settore; il tutto, però, partendo dalla eliminazione di una serie di luoghi comuni che, al di là delle intenzioni, rischiano di pregiudicare un percorso serio. Giova passarli in rassegna, se non altro per evitarli.
1° luogo comune. Si dice: in Europa gli immigrati sono una minoranza, e ciò deve far mettere da parte gli allarmismi. In Italia, in particolare, gli immigrati sono meno del 10% della popolazione, in linea con la tendenza europea, che vede presenti circa 50 milioni di immigrati rispetto ai 500 milioni di cittadini dell’UE. Il limite di questo ragionamento, tendenzialmente rassicurante, è che osserva il fenomeno come se fosse raffigurabile attraverso le fotografie, quando invece esso è un film. Solo il filmato permette di cogliere il punto di avvio, la tappa alla quale ci si trova, la velocità di marcia, e quindi fa proiettare la dimensione quantitativa da oggi a 10, 20, 50 anni. Alla data del 30 novembre 2009 (ultimo dato disponibile) le persone extracomunitarie presenti in modo regolare nel territorio italiano erano 2.675.417 (di cui 4.204 titolari di carta di soggiorno per familiare di cittadino UE, 986.300 titolari di permesso di soggiorno per lungo periodo, 626.908 minori infraquattordicenni iscritti sul titolo del genitore/ affidatario, 2.048.509 stranieri titolari di permesso di soggiorno valido); questo dato è al netto di coloro che nel frattempo sono diventati cittadini comunitari, a seguito dell’ingresso nell’UE dei Paesi da cui provenivano (per i quali non si può più fare riferimento al censimento basato sul permesso di soggiorno), e dei regolarizzandi in base all’ultimo provvedimento: alla ricerca di un termine di confronto complessivo omogeneo, la somma con tali voci renderebbe il totale dei residenti regolari di provenienza straniera pari a circa 4.500.000 persone. Nel 1990 gli immigrati regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale erano 548.193 (di cui 108.544 cittadini comunitari e 439.649 extracomunitari), nel 1995 erano 707.366 (122.890 comunitari e 584.476 extracomunitari), nel 2000 erano 1.388.153 (151.799 comunitari e 1.236.354 cittadini extracomunitari), nel 2005 erano 2.271.680 (di cui 229.530 comunitari e 2.042.150 extracomunitari): dunque, nel 2009 si è arrivati a circa 10 volte le presenze del 1990. Seguendo i ritmi degli ultimi vent’anni, in Italia gli immigrati regolari arriverebbero a 12 milioni nel 2030 e a 20 milioni nel 2050. Il film non costituirebbe una novità: la Svezia ha 9 milioni di residenti e 1,5 milioni di immigrati, l’Olanda 13 milioni di residenti e 3 milioni di extracomunitari. L’entità e la consistenza di queste proporzioni, peraltro in crescita, non permettono la realizzazione di una integrazione degna di questo nome: una integrazione effettiva, non meramente declamata, ha bisogno di gradualità e di possibilità di inserimento sociale e lavorativo reale.
2° luogo comune: accogliere quanti più immigrati possibile corrisponde a una istanza etica, collegata, fra l’altro, alla esigenza di fornire un doveroso contributo contro la fame e il sottosviluppo e a un vago solidarismo buonista. In proposito, è lecito chiedersi: in base a quali elementi per noi sarebbe meno oneroso e per il Terzo mondo sarebbe preferibile trasferire in Europa milioni di extracomunitari piuttosto che sostenerli nei Paesi d’origine? Chi sottolinea positivamente la presenza fra gli immigrati di ottimi ingegneri, di bravi informatici, di medici e di infermieri capaci non riflette a sufficienza sul costo per le zone di provenienza rappresentato dall’impoverimento delle loro risorse umane. Il valente medico arrivato da uno Stato del Centro Africa non è indispensabile per i sistemi sanitari europei, lo è invece nel Ruanda o nel Ghana. All’istanza etica ci si richiama per fondare un riconoscimento ampio del diritto di asilo. L’Italia da questo punto di vista vive un paradosso: è una delle Nazioni che può vantare nel mondo, in assoluto e in proporzione alla popolazione residente, il numero più elevato di accoglimenti di domande di asilo e di protezione umanitaria, e al tempo stesso è quella in cui, grazie alle polemiche sollevate da un team politico, mediatico, di associazioni di settore e giudiziario, sembra che l’asilo sia quotidianamente denegato. Al netto delle polemiche, va detto con chiarezza che invocare lo status di rifugiati non può essere lo strumento per entrare senza permesso di soggiorno: non può affermarsi il principio secondo cui la protezione va riconosciuta – anche in assenza di persecuzione o di discriminazione – a chiunque provenga da un Paese non democratico o al cui interno vi siano sperequazioni economiche, cioè a chiunque arrivi da uno degli Stati del Terzo Mondo.
3° luogo comune: il decremento demografico fa sì che l’Europa abbia bisogno di immigrati, anche per svolgere quei lavori che l’europeo non è più disponibile a fare. Ora, se è vero che il Vecchio continente conosce da decenni un forte calo di nascite, c’è da chiedersi se la soluzione del problema consiste davvero nel far giungere immigrati senza limiti. C’è qualche ragione per dubitarne: a) gli extracomunitari, grazie ai loro salari bassi, mantengono in vita per un certo tempo, in ambiti economici in crisi, posti che altrimenti scomparirebbero. Ma è semplicemente una questione di tempo: prima o poi i posti di lavoro inesorabilmente scompaiono; in ampie aree dell’Europa la difficile situazione del tessile o del calzaturiero è dipesa non dal calo demografico, ma dai costi minori dei prodotti cinesi. Alla fine, nonostante le paghe inferiori degli immigrati che lavorano da noi, tante aziende hanno egualmente chiuso i battenti, e nell’insieme probabilmente i costi riguardanti l’arrivo di nuovi immigrati hanno superato i benefici della loro presenza; b) con alcune significative eccezioni (si pensi alla collaborazione domestica e alle c.d. badanti, molte delle quali però sono cittadine comunitarie), va detto che i lavori che nessuno desidera in realtà sono i lavori che l’europeo non vuole se il salario non è attraente. La questione non va vista dal lato dell’indisponibilità del lavoratore a determinati impieghi, bensì dal lato della disponibilità del datore di lavoro a occupare, talora in nero, extracomunitari che costano di meno; la conseguente alterazione del mercato del lavoro fa sì che in alcune Nazioni aumenta la disoccupazione ma al tempo stesso cresce l’immigrazione, e quindi l’occupazione in nero o con sottopaghe degli extracomunitari.
4° luogo comune: sempre a causa del calo demografico, oggi ci sono pochi giovani e molti anziani, con ripercussioni sulla tenuta del sistema pensionistico, rispetto al quale l’arrivo di nuovi lavoratori da fuori i confini europei avrebbe l’effetto di incrementare la platea contributiva. Riprendiamo l’analogia fra il fotogramma e il film: i giovani lavoratori immigrati di oggi crescono anche loro, e prima o poi diventeranno anziani pensionati; peraltro il loro salario attuale, mediamente non elevato, è accompagnato da versamenti contributivi egualmente bassi, e così al futuro incremento del numero dei pensionati non corrisponderà un parallelo incremento della quantità di contributi.
5° luogo comune: nutrire riserve per la positività di una immigrazione larga significa dimenticare la nostra emigrazione, e riproporre nei confronti di chi oggi viene in Italia gli stessi pregiudizi e le medesime ingiustizie che hanno subito i nostri antenati. Quest’argomento viene adoperato anche per sollecitare percorsi più rapidi di ottenimento della cittadinanza. Il limite di questo ragionamento sta nel sovrapporre periodi storici e dinamiche del tutto diverse: chi dall’Italia si trasferiva col piroscafo nelle Americhe, o prendeva il treno con la valigia di cartone per i Paesi del Nord dell’Europa, in larga parte ci andava con la prospettiva di restarci. Chi oggi viene in Europa da aree meno sviluppate pensa di stabilirsi mediamente solo in un terzo dei casi: l’altro 70% si pone l’obiettivo di mettere da parte dei risparmi, di acquisire mestieri e/o professionalità, di far frequentare ai figli le nostre scuole, quindi di rientrare dopo un numero apprezzabile di anni nel Paese d’origine per far fruttare i risparmi e le conoscenze apprese. A che cosa serve a costoro la cittadinanza? Chi di loro realmente la chiede o la desidera?
In tal senso va perseguita – e può costituire un pilastro del “modello italiano” – una politica di reinserimento dei lavoratori immigrati nei paesi di origine, che punti a garantire nei fatti l’equilibrio tra la soddisfazione in modo flessibile del fabbisogno di mano d’opera dell’economia italiana e la necessità di nuove opportunità di lavoro dei Paesi di provenienza. Va costruita quella che potrebbe definirsi una “immigrazione rotazionale”, basandola su un doppio binario: percorsi di inserimento non virtuale di chi viene in Italia e in Europa e percorsi di rientro incentivato nei luoghi di provenienza, tesi a collocare nel modo più adeguato e soddisfacente chi ha maturato competenze e capacità di contribuire allo sviluppo del proprio Paese. Ciò richiede in modo decisivo il rafforzamento della cooperazione, indirizzando le scelte sia delle istituzioni comunitarie, sia degli enti territoriali italiani, sia – per quanto si lascino coinvolgere – delle istituzioni degli Stati di provenienza.
Tornando all’analogia con il passato, va ricordato che i nostri emigranti si recavano in contesti sociali, e in senso lato culturali, non opposti a quelli di provenienza, per lo meno quanto a confessione religiosa e a principi essenziali; ma una parte significativa degli attuali immigrati hanno riferimenti molto diversi dai nostri. E’ difficile negare il peso sociale della religione, e i riflessi che essa esercita sullo spazio pubblico, anche solo nelle manifestazioni esterne: come in passato nessuno si scandalizzava se per le strade di New York gli italiani portavano in processione S. Antonio, oggi nessuno protesta se immigrati sudamericani portano le loro statue della Madonna in processione per le vie di qualche grande città italiana. I problemi sorgono, e le reazioni si attivano, se migliaia di musulmani pregano Allah davanti al Duomo di Milano, magari inserendo nelle preghiere invettive contro gli USA e Israele. E’ indubbio che, anche nelle comunità di immigrati, vi siano differenti gradazioni di islam e che processi di assimilazione siano possibili; ma è altrettanto indubbio che l’islam nel suo insieme ha delle specificità, negare le quali è ottusamente relativistico. Queste specificità rendono difficile l’assimilazione dell’islam alla cultura europea per voci fondamentali quali il rapporto fra uomo e donna, fra religione e politica, fra fede e ragione, fra appartenenza confessionale e violenza.
C. Provare a liberarsi da questi luoghi comuni non vuol dire rinunciare a perseguire una posizione di equilibrio, o peggio scadere in una sorta di criptorazzismo: significa semplicemente non farsi illusioni. Il percorso è lungo e complicato; soprattutto, non tollera scorciatoie. Un esempio di scorciatoia è quell’insieme di proposte che vanno nella direzione della cittadinanza breve. E’ una scorciatoia pericolosa, perché scambia la fine con l’inizio: immagina la cittadinanza come uno strumento di integrazione, e non invece – come noi sosteniamo che debba essere – come la parte conclusiva di un percorso di integrazione; la via formalmente e sostanzialmente corretta non può prescindere dalla scansione “permesso di soggiorno” (connesso a un lavoro regolare, valido fino a 2 anni, rinnovabile) – “carta di soggiorno” (che presuppone 5 anni di residenza, un lavoro e un alloggio secondo le norme dell’edilizia residenziale pubblica, assenza di seri pregiudizi penali, e che è valido senza necessità di rinnovo ed è revocabile solo se si commettono reati) – “cittadinanza”: ma se la cittadinanza si può ottenere dopo 5 anni, esattamente come la carta di soggiorno, la gradualità che si basa su quest’ultima non ha più senso, e viene compromessa la logica dell’intero sistema.
Anche per il riconoscimento delle cittadinanze l’incremento in Italia è avvenuto parallelamente a quello delle presenze degli stranieri regolari: nel 1990 i provvedimenti furono 3.809 (3.475 per matrimonio e 334 per residenza); nel 1995 furono 8.051 (6.979 per matrimonio e 1.072 per residenza); nel 2000 furono 9.554 (8.123 per matrimonio e 1.431 per residenza); nel 2005 furono 19.266 (11.854 per matrimonio e 7.412 per residenza); nei primi nove mesi del 2009 – ultimo dato aggiornato – sono stati 28.565 (12.314 per matrimonio e 16.251 per residenza): la proiezione sull’intero anno porta a quota 40.000, cioè al decuplo delle cittadinanze concesse vent’anni fa, con una prevalenza per la prima volta della residenza sul matrimonio.
La questione cittadinanza va inserita in un contesto che parta anzitutto da un corretto e organico governo dell’immigrazione. Se l’immigrazione è un dato della nostra realtà che nessuno può pensare di abolire, tuttavia non deve svolgersi senza una guida e senza direttrici di fondo. Governo dell’immigrazione significa, sul piano strutturale, puntare a politiche omogenee in sede UE, per la difficoltà di immaginare decisioni differenti per confini nazionali. Significa, nel proprio territorio, coinvolgere in via continuativa tutte le realtà istituzionali interessate dal fenomeno: dai ministeri a vario titolo chiamati in causa, alle regioni e agli enti locali. Gli strumenti di coordinamento delle varie competenze, centrali e periferiche, non mancano nella legge in vigore, attendono solo di essere compiutamente utilizzati. Governo dell’immigrazione significa anche – e ci si sta muovendo in questa direzione – risolvere problemi di vita quotidiana, che rendano la presenza fra di noi meno inutilmente complicata: ridurre le code davanti agli sportelli, dimunuire i tempi per ottenere documenti essenziali, a cominciare dal rinnovo del permesso di soggiorno, garantire la disponibilità di alloggi decorosi e la fruizione di servizi in condizioni di parità con gli italiani, migliorare l’approccio con la nostra realtà istituzionale.
Norme introdotte di recente nell’ordinamento puntano a favorire l’effettiva integrazione di ogni singolo immigrato. Nel luglio 2009, nell’ambito del “pacchetto sicurezza”, il Parlamento ha previsto per la prima volta l’”accordo di integrazione” (inserendolo come art. 4 bis nel testo unico sull’immigrazione). Esso consiste in questo: all’atto della richiesta di permesso di soggiorno – quale condizione per il rilascio dello stesso – l’immigrato sottoscrive l’assunzione di impegni, articolati per crediti e per obiettivi, da onorare nel periodo di validità del permesso. La perdita integrale dei crediti determina la revoca del permesso di soggiorno e l’espulsione dello straniero. Al ministero dell’Interno è in corso la stesura del decreto attuativo che darà sostanza all’accordo; nella discussione al Senato il Governo ha accolto un ordine del giorno, in base al quale il decreto ministeriale subordinerà l’assegnazione dei crediti relativi all’accordo a una serie di requisiti: livello adeguato di conoscenza della lingua italiana; adesione alla Carta dei valori (promossa dal ministro dell’Interno Amato il 23 aprile 2007); conoscenza delle regole di base del nostro ordinamento. Nello stesso ordine del giorno si prevede che, al momento del rinnovo del permesso di soggiorno, lo straniero incrementa i crediti attribuitigli se: 1) nei due anni precedenti non ha violato norme di comportamento da cui derivi la decurtazione; 2) ha superato un corso che verifichi il livello di integrazione sociale e culturale e il raggiungimento degli obiettivi di integrazione sottoscritti; 3) mostra adeguata partecipazione economica e sociale alla vita della comunità nazionale e locale. I crediti subiranno decurtazioni in proporzione alla gravità dell’infrazione commessa, nei casi di violazioni del codice penale e gravi illeciti amministrativi o tributari. La costruzione nei fatti di un sistema che faccia effettivamente funzionare l’accordo di integrazione costituirà la base per il progressivo inserimento nella nostra realtà nazionale, a conclusione del quale si colloca il riconoscimento della cittadinanza.
D. Governo dell’immigrazione significa però, oltre che collegare la disciplina dei flussi a procedure meno burocratizzate, non agganciarsi esclusivamente agli indici del mercato del lavoro. Quello su cui è necessario riprendere una riflessione non sommaria né demonizzante è tentare di orientare gli arrivi nei differenti Paesi europei sulla base di consonanze culturali in senso lato, proprio per permettere la migliore integrazione: non si tratta di promuovere impossibili preferenze etniche, ma di essere consapevoli che la convivenza riesce meglio quanti più numerosi sono gli elementi che si hanno in comune. Una ipotesi del genere, lungi dal possedere connotazioni di discriminazione razziale, è l’esito del buon senso: per ragioni ovvie, un somalo ha una facilità di integrazione in Italia certamente superiore rispetto a un maghrebino, mentre in Francia chi proviene dalla Tunisia trova un terreno più favorevole rispetto a chi proviene dallo Sry Lanka.
In quest’ottica, non dobbiamo temere di riaffermare la nostra identità culturale: anzi, dobbiamo convincerci che l’immigrazione pone a rischio le società che non riescono a mantenere in modo chiaro e deciso la propria identità. La rinuncia a riconoscere le proprie radici cristiane è stata negli ultimi anni per l’Europa il sintomo più evidente della incapacità a manifestare la sua identità. La Corte europea dei diritti dell’uomo alterna, nelle decisioni rivolte ai singoli Stati, l’obbligo di rimuovere il crocifisso al divieto di espellere i terroristi. L’introduzione della pillola abortiva dove ancora non esiste avviene per impulso di istituzioni europee. In alcuni Paesi dell’UE i corsi sulla cittadinanza proposti agli immigrati esaltano il presunto “diritto all’aborto”. In troppe scuole italiane la tradizionale memoria del Natale – che richiama un comune dato di civiltà, al di là dell’appartenenza confessionale – viene sostituita da amorfe “feste della luce”, o da generiche recite scolastiche dedicate a tutt’altro, mentre la progressiva ritirata del presepe dai luoghi pubblici comincia a essere seguita anche dalla stilizzazione dell’albero (che è pur sempre “di Natale”, e quindi rischi di non essere religiosamente corretto). In Olanda ai nuovi immigrati viene fatto vedere un video che riassume i “valori olandesi”: in esso due omosessuali si scambiano effusioni in pubblico e una bagnante prende il sole in topless. Non so se gli olandesi riconoscono in maggioranza queste immagini come loro “valori”, né so se la maggioranza degli europei ritengono l’aborto qualificante e simbolo di civiltà tale da costituire baluardo di integrazione, ma ho l’impressione che larga parte degli immigrati di fede islamica traggano spunto da tutto questo per confermare il loro sentimento di superiorità nei nostri confronti, e – più in generale – che su queste voci una persona di buon senso non può immaginare di costruire una immagine forte dell’Europa e della sua identità. Il dovere dell’identità è strettamente connesso a una politica seria dell’immigrazione, e impone una effettiva unità attorno ai principi che connotano l’identità, una solidarietà di testa e di cuore fra coloro che la perseguono, un metodo caratterizzato da senso di realtà. Approcci buonistici e ottime intenzioni devono fare i conti con l’oggettività del reale, senza falsi miti, pie leggende o dannose edulcorazioni. Abbiamo la storica responsabilità di non scaricare la questione sulle future generazioni, e quindi di non favorire la formazione di un consistente numero di “cittadini” culturalmente avulsi dal tessuto nazionale. Questa responsabilità si coniuga con l’antica consapevolezza, di cui sono tragica riprova gli orrori del secolo scorso, che “il mondo è un purgatorio, che viene trasformato in inferno da coloro che vogliono farne un paradiso”. Nostro compito è di rendere il mondo in cui la Provvidenza ci ha chiamato a vivere un po’ meno purgatorio, senza per insipienza avvicinarlo all’inferno: la cui via – come tutti sanno – è lastricata di buone intenzioni.
* Docente Materie Giuridiche
[divider style=”tiny”][/divider]
Totale visite al 15/12/2013: 301