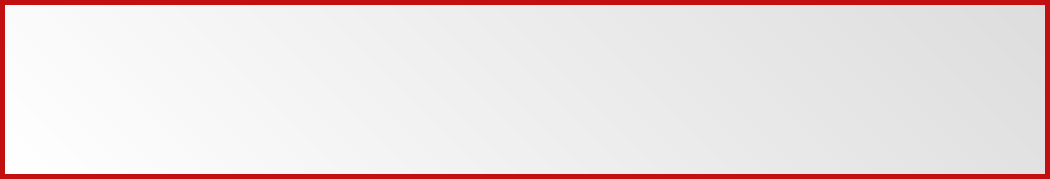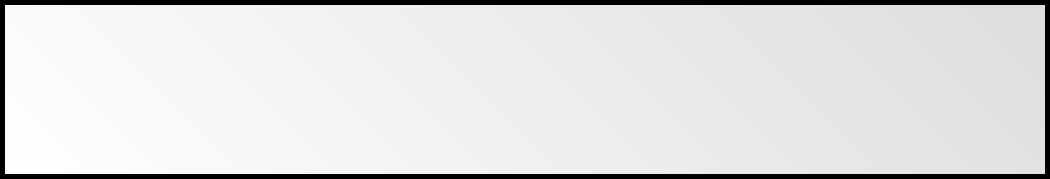Mutamenti strutturali in Italia a seguito Guerra 1915-18
2. L’affermarsi di una diversa concezione dell’economia.
Come abbiamo detto, chi ha posto attenzione al cinquantennio precedente alla Grande guerra, in Italia e fuori di essa, ha constatato l’esistenza degli alti e bassi nel commercio e le ondate ricorrenti di depressione economica e di disoccupazione che hanno intersecato la linea ascendente di uno sviluppo secolare. Ma del pari non può essere ignorato che a metà del secondo decennio del Novecento venne a maturazione un complesso di tendenze politiche destabilizzanti per il sistema: le esigenze di libertà dei popoli sottomessi, quelle di unione delle nazionalità separate, l’azione di una cultura volta a nuovi orizzonti[4]; e, ancora, non si devono trascurare due elementi essenziali: l’attività economica individualistica, lasciata agli equilibri spontanei tendenti spesso all’avventurismo anarchico, e l’aspirazione delle masse contadine e operaie a influire su decisioni dalle quali erano escluse e che pur le riguardavano.
La guerra fu quindi il prodotto, non del caso, ma di tutte queste cause. Tuttavia è innegabile che «se si confrontano le difficoltà di allora con quelle che vennero poi, si deve riconoscere che esse appartenevano a un ordine di grandezza inferiore»[5].
Riguardo all’influenza che ebbero sull’attività economica la guerra e i mutamenti politici che seguirono si devono considerare le vaste e profonde trasformazioni nelle condizioni fondamentali della domanda e dell’offerta di merci e servizi a cui l’attività economica dovette adattarsi in maniera così vasta e diffusa. Per la prima volta nella storia dell’umanità niente e nessuno fu risparmiato, fosse o meno coinvolto negli eventi bellici. Variò solo il grado di questo coinvolgimento.
I bisogni della guerra fecero sorgere enormi impianti meccanici che la cessazione delle ostilità rese in gran parte superflui. La guerra ruppe l’unità del mercato mondiale e i trattati di pace aggravarono questa “rottura”. La lotta che doveva por fine per sempre agli urti fra le nazioni – come si affermava dalla propaganda di tutti i Paesi – diede invece fondamento a nuovi e più laceranti risentimenti sui quali fatalmente si alimentarono le dottrine nazionalistiche dei popoli che prendevano coscienza della propria identità o che rivendicavano diritti fondamentali che venivano negati. Questi mutamenti, anche a causa della loro discontinuità, determinarono grandi distruzioni di capitali e provocarono restrizioni alla libertà di iniziativa economica. Da qui derivò una diminuzione nel rendimento dei fattori della produzione.
Per oltre quattro anni le energie produttive di tutti i Paesi belligeranti (e anche di quelli non impegnati direttamente) furono rivolte a sostenere lo sforzo bellico. Spesso si trattava di beni che venivano distrutti appena prodotti oppure che diventavano inutili appena cessata la ragione per la quale erano stati fabbricati. La rottura dell’unità del mercato mondiale, causata dalla guerra e dai trattati di pace, restrinse l’applicazione del sistema della divisione del lavoro, e quindi limitò quell’aumento di ricchezza che la divisione del lavoro produce e ridistribuisce creandone di ulteriore.
Insieme con queste trasformazioni, a cominciare dalla Prima guerra mondiale intervennero altri mutamenti decisivi per gli eventi che hanno caratterizzato l’epoca successiva. Poiché a causa delle distruzioni di capitale e dell’abbassamento della produttività il sistema economico andava perdendo le sue spontanee capacità di adattamento, si rendeva necessario un raggiustamento esterno di così grande entità quale non si era mai visto prima nella storia economica. Tale raggiungimento consistette nell’accentamento del controllo pubblico sulle attività produttive attraverso misure che incisero in maniera irreversibile sia sulla struttura degli organi pubblici a ciò preposti, sia sugli organismi economici che ne derivano. Oltre al naturale “spirito di conservazione” degli enti burocratici, lo stesso sistema produttivo che ne derivò, la mentalità assunta dagli operatori economici e l’estensione dell’intervento pubblico per altri fini (di giustizia sociale, di ordine pubblico, di strategia politica) operarono condizioni definitive che resero impossibile il ritorno alle situazioni precedenti.
Il raggruppamento delle imprese industriali in grandi consorzi, la determinazione autoritaria dei prezzi e dei salari, l’imposizione di metodi di contrattazione collettiva ebbero certamente la loro giustificazione nelle necessità della guerra che, per la prima volta nella storia dell’umanità, impegnando tutte le risorse possibili, obbligava a uscire dagli automatismi del mercato e dagli equilibri derivanti dal libero confronto fra le utilità dei singoli.
Nella relazione ufficiale del Comitato governativo creato all’epoca e pubblicato dopo la fine del conflitto si legge: «La mobilitazione industriale [ai fini bellici] introdusse […] nel campo sociale un istituto giuridico che molti ritenevano essere un’utopia da pensatori: l’istituto dell’arbitrato obbligatorio nella questione tra capitale e lavoro»[6].
3. La rottura dell’unità monetaria internazionale e la pressione delle nuove forze sociali.
A complicare il quadro derivante dall’interventismo statale a fini bellici sopravvenne la rottura dell’unità del sistema monetario internazionale. Nei quarant’anni che precedettero la guerra i sistemi finanziari dei principali Paesi del mondo erano legati fra loro dal regime aureo internazionale.
«Il commercio fra i vari Paesi si svolgeva in base ai cambi che oscillavano se non entro limiti strettissimi. I capitali si spostavano da una parte all’altra del mondo, se non con la stessa facilità con cui essi si muovevano all’interno di ciascun Paese, per lo meno in modo da determinare press’a poco gli stessi effetti sul volume di credito disponibile»[7].
La conseguenza di questa mobilità senza intralci – naturalmente con i limiti dell’epoca in cui i trasporti, le comunicazioni e le tecniche non consentivano ancora la rapidità dei decenni successivi – garantiva per le merci, che erano oggetto di transazioni internazionali, prezzi omogenei su tutte le piazze. Le variazioni dei prezzi di conseguenza avvenivano contemporaneamente in quanto i livelli dei costi mantenevano ovunque lo stesso rapporto e solo poche volte si manifestavano segni di squilibrio tra prezzi e costi. La guerra modificò radicalmente tutto ciò. Fin dai primi giorni del conflitto, in ciascuno dei Paesi belligeranti si presero dei provvedimenti che equivalsero a un abbandono di fatto, anche se non ufficiale, del regime aureo. Dei grandi centri finanziari, gli Stati Uniti furono gli unici a conservarlo; negli altri, non solo venne sospesa la convertibilità dei biglietti, ma in ognuno di essi si ricorse, per provvedere alle spese di guerra, alla deliberata inflazione.
Dalla pratica di finanziare la spesa pubblica, corrente o di investimento, attraverso l’emissione di moneta, derivò in gran parte quell’aumento dei prezzi che dalla Prima guerra mondiale in poi colpì, in misura diversa e con vari gradi di accelerazione, tutti i Paesi del mondo. La situazione generale descritta ha inciso particolarmente sulla evoluzione del sistema economico italiano in quanto la nostra nazione ha sempre dovuto far i conti, oltre che con risorse naturali insufficienti rispetto a una popolazione crescente, con gli squilibri ciclici originati dall’esterno. All’inflazione interna si è così sempre – salvo taluni periodi della politica economica fascista – sommata l’inflazione importata.
È chiaro che – dovendo l’economia italiana importare dall’estero le materie prime ed energetiche di cui è sprovvista, e che sono necessarie al suo sviluppo, e dovendo poi esportare parte dei prodotti ottenuti dalla loro trasformazione, insieme alla produzione interna, derivata interamente dalle materie prime nazionali (p.es. quelle agricole), al fine di compensare le partite passive della sua bilancia – l’Italia risente doppiamente delle instabilità esterne e ne subisce costantemente le ripercussioni. A questa condizione strutturale si sommarono i problemi posti dalle nuove leve politiche, sociali ed economiche che premevano per entrare a far parte dei centri decisionali della nazione.
«Nuove correnti entravano ormai nella nostra vita politica, nuovi problemi si affacciavano ogni giorno, nuove forze sorgevano con le quali il governo doveva fare i conti», scriveva Corbino[8] a proposito del «nuovo periodo storico», succeduto già all’inizio del secolo al fallimento della politica reazionaria culminata da provvedimenti del Pelloux.
Di questa esigenza si rendeva conto Giolitti il quale, a proposito del diffondersi delle Camere del lavoro, riteneva che esse dovevano essere considerate legittime. Tuttavia la convinzione di Giolitti – pur nelle limitazioni dell’auspicio per una partecipazione solo formale alla vita sociale ed economica della nazione – non si era tradotta nella realtà e, insieme con gli squilibri derivanti al sistema del fervore individualistico nell’espansione economica del primo decennio del secolo, maturavano le tensioni sociali accumulatesi proprio a causa della mancata apertura alle nuove esigenze. La «settimana rossa» ne fu l’espressione più significativa anche se abortita a causa dell’impreparazione delle masse e dell’immaturità politica di chi se ne era assunta la rappresentanza.