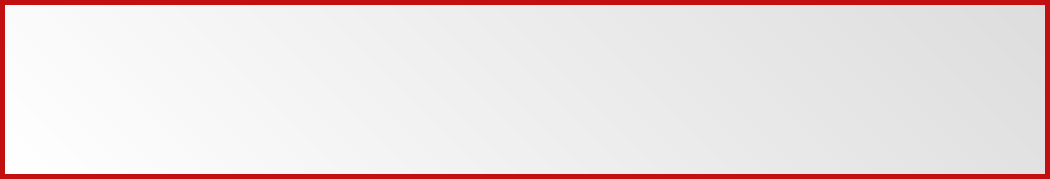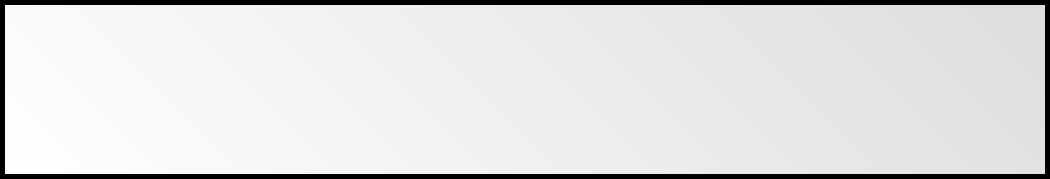Mutamenti strutturali in Italia a seguito Guerra 1915-18
4. La preoccupazione inglese per l’affermarsi della potenza tedesca come principale causa economica del conflitto.
Abbiamo visto finora, tra le molteplici cause della Prima guerra mondiale, quelle dell’ordine generale. Tra quelle di natura particolare se ne possono individuare tre da considerarsi preponderanti: le conseguenze delle lotte per l’unità e l’indipendenza delle nazionalità, la rivalità industriale e commerciale tra la Gran Bretagna e la Germania e l’affacciarsi come potenze mondiali extraeuropee degli Stati Uniti in America, e del Giappone in Asia.
«Nel 1914 – scriveva Lumbroso un decennio dopo – la Gran Bretagna era superiore ad ogni altra potenza: anche alla Russia e alla nordamericana! E la vastità dell’Impero coloniale britannico corrispondeva nel 1914 pienamente allo sviluppo colossale delle sue industrie e dei suoi commerci; ma era un apice, un “nec plus ultra, sic stantibus rebus” e sarebbe venuta rapida la decadenza se l’Ingjhilterra fosse rimasta stazionaria, mentre la Germania progrediva di anno in anno, si può dire di mese in mese»[9].
Se si esamina infatti lo sviluppo del commercio delle maggiori potenze del mondo, nel periodo che va dal 1885 al 1912, secondo gli schieramenti politico-militari precedenti la guerra, si ha anzitutto la sensazione precisa della poderosa ascesa tedesca. Contemporaneamente si può osservare che, pur in altre dimensioni, il commercio internazionale dell’Italia – come abbiamo già anticipato – eguagliava quello dell’impero austro-ungarico. Di tutte le grandi potenze, quella il cui commercio aveva fatto i maggiori progressi era stata la Germania che era passata dagli 8 miliardi del 1885 ai 26 del 1912 (più del triplo) seguita, come incremento, dall’Inghilterra che era passata da 17 a 30 miliardi (meno del doppio). In cifre assolute l’Inghilterra era ancora la maggiore potenza mondiale, ma continuando con quel ritmo la Germania avrebbe finito per eguagliare e superare la Gran Bretagna.
Caratterizzarono tale sviluppo i progressi qualitativi e quantitativi dell’industria pesante attraverso l’introduzione di nuovi metodi di produzione (Bessemer, Martin, Thomas) e il rapido aumento della produzione. Prima l’acciaio e poi la ghisa si imposero sui mercati mondiali; la produzione di acciaio tedesco nel 1893 superò quella inglese. Oltre che nel siderurgico anche in altri comparti, come quello chimico ed elettromeccanico, si fecero progressi enormi. Alla vigilia della Prima guerra mondiale la Germania garantiva il soddisfacimento dell’85% del fabbisogno mondiale dei coloranti. Come scrive Pescosolido «ai ritmi di sviluppo tedeschi in questi settori, né la Francia, né l’Inghilterra si mostravano in grado di tenere il passo»[10].
Accanto a questa realtà va tenuto presente che una precisa fisionomia aveva assunto l’espansionismo imperialistico legato alla rivoluzione industriale. L’imperialismo inglese – nato sul mare con i commerci oltre oceano e affermatosi decisamente contro quello spagnolo con la distruzione dell’Armada Invencible – dopo aver contenuto l’espansionismo olandese, si era protratto e rafforzato con lo sviluppo industriale e l’introduzione del vapore e delle macchine utensili. Il possesso delle miniere di carbone e di ferro e lo spirito intraprendente del capitalismo protestante avevano favorito il Regno Unito dandogli aggressività insieme militare ed economica.
Fuori d’Europa, nel corso del XIX secolo, gli Stati Uniti avevano abbandonato la dottrina di Monroe («nessun intervento degli europei in America e nessun intervento degli americani in Europa» e, fatta la guerra alla Spagna per il possesso di Cuba, erano entrati in gara con le maggiori potenze industriali del mondo; nel mezzo secolo che aveva preceduto la Prima guerra mondiale il Giappone era passato dalla più completa e voluta segregazione alla più decisa e programmata partecipazione alla vita politica ed economica mondiale.
Sulla base delle concezioni elaborate, verso la fine del XIX secolo dall’antropologo e geografo tedesco Friedrich Ratzel[11], il francese Bernard Brunhes[12] interpretò le vicende che vanno dalla proclamazione dell’Indipendenza americana alle «Dichiarazioni» della Grande guerra come il risultato della «lotta per gli spazi», una teoria socio-economica derivata dalla lotta per la vita (struggle for life) di Darwin. Dice Lumbroso che «la conquista di nuove terre da dominare e da sfruttare in tutto il mondo, e di nuovi mercati per i propri prodotti, [rispondeva] al bisogno, nelle nazioni più attive, di dar sfogo al proprio capitalismo industriale […] Questo spiega perché più delle terre continentali da strappare al vinto, la vera posta del 1914-18 sia stata quella di strappargli le sue colonie»[13].
Non c’è dubbio che la Germania avrebbe preferito una sua espansione pacifica sui mercati mondiali, ma ne era impedita dalla dominazione inglese dei mari. Non va dimenticato che l’impero britannico nel 1914 contava ben 10.123 unità navali per 20 milioni e 523 mila tonnellate di stazza lorda, mentre alla stessa data la Germania, che pur aveva la più forte marineria europea ed era la seconda del mondo, disponeva soltanto di 2.090 unità per 5 milioni e 135 mila tonnellate di stazza lorda[14].
L’Inghilterra aveva combattuto, per affermare il proprio imperialismo, prima la Spagna, poi l’Olanda, poi la Francia e ora toccava alla Germania. Si è per molti anni sostenuto che in Europa ogni nazione fosse dedita alla pace fuorchè la Germania, ma sia nelle occasioni scatenanti della guerra che nelle cause lontane le cose stanno diversamente. Circa le modalità va ricordato che per sostenere gli Slavi del Sud, attaccati dall’Austria, la Russia per prima mobilitò l’esercito e che solo in conseguenza di ciò la Germania inviò l’ultimatum. Il Lumbroso si domanda a tal proposito: «La guerra è piuttosto voluta da chi per primo fa la mobilitazione generale o da chi manda un ultimatum per farla interrompere?».
In realtà la prima mobilitazione fu fatta dalla Russia (tra l’altro contro il parere dello Zar) per gli incitamenti giunti a Pietroburgo da Parigi e da Londra. Errori diplomatici e politici furono commessi tanto dalla Triplice Alleanza che dalla Triplice Intesa, ma, come affermò il diplomatico francese Alfred Fabre-Luce, «la Germania e l’Austria han fatto ognuna il gesto che rendeva la guerra solo possibile, [mentre] l’Intesa ha fatto quelli che la rendevano certa».
L’errore dei governi di Germania e Austria fu di basarsi sullo spirito e sulla lettera dei trattati e di pensare che i singoli governi si sarebbero comportati secondo i loro contenuti giuridici. Non pensavano che «le mene del Foreign Office» – come dice sempre il Lumbroso – avevano da tempo organizzato l’accerchiamento della Germania da oriente con la Russia e da occidente con la Francia, e che ambedue queste nazioni avrebbero ingannato scientemente le loro nazioni sull’ordine cronologico delle varie mobilitazioni generali.
Certo i tedeschi, inviando l’ultimatum alla Russia, procedettero con la loro consueta imprudenza politica e con assoluta ignoranza della psicologia dei popoli. Winston Churchill, quando quattro anni prima dello scoppio della guerra, nel 1911, divenne Primo Lord dell’Ammiragliato, ossia ministro della Marina, ebbe dal Primo ministro Asquit l’ordine di preparare la flotta britannica alla guerra («to put the Fleet in a state of istant and constant readiness for war»). Naturalmente anche i tedeschi affinavano i propri strumenti bellici terrestri e navali, ma non si può sostenere con ciò che solo la Germania facesse una preparazione aggressiva nei confronti dei pacifici, impreparati e «sorpresi» rivali della sua espansione coloniale.
D’altra parte le cifre delle spese militari parlano chiaro: nel 1911, la Gran Bretagna, la Francia e la Russia spesero per nuove costruzioni navali 24 milioni e ¼ di sterline, contro 11 milioni e ¾ della Germania; nel 1912 l’Intesa ne spese 30.145.000 contro 11 e mezzo della Germania; nel 1913 l’Intesa ne spese quasi 38 milioni e la Germania 11; nel 1914 alla vigilia della guerra, l’Inghilterra con gli alleati ne votò 43 milioni e mezzo contro i 10.250.000 – sempre calcolati in sterline – concessi in Germania alla «flotta germanica d’alto mare» dell’ammiraglio Tirpitz. In totale l’Intesa spese per le sole costruzioni navali 108.450.000 sterline più della Germania[15].
Il problema era per la Gran Bretagna di impedire che la Germania diventasse da grande potenza europea una grande potenza mondiale e questo, secondo i propri interessi, fu l’obiettivo perseguito con abile e tenace trama.
Com’è noto, gli inglesi vi riuscirono, ma ritardarono soltanto il loro declino in quanto più a occidente si andava imponendo la potenza nordamericana grazie a Wilson che aveva capovolto la dottrina di Monroe, pur di espandere l’influenza e l’autorità degli Stati Uniti sul mondo. E ciò fu fatto a scapito prima di tutto del Regno Unito.
5. Il dibattito economico pro Triplice o pro Intesa.
In Italia numerosi furono i sostenitori della tesi che gli interessi nazionali coincidevano con le fortune della Triplice Alleanza. Lo schieramento era, naturalmente, più filotedesco che filoaustriaco – anche in omaggio alla freschissima tradizione risorgimentale – e comprendeva oltre che uomini politici (Giolitti, per es.) e militari (il gen. Pollio, per es.) anche uomini di cultura (Benedetto Croce, per es.). Va ricordata poi la forte influenza tedesca nel settore bancario e dei finanziamenti industriali.
Luigi Einaudi, già allora noto economista, nel gennaio 1915, da una posizione tendenzialmente antinglese, auspicava per l’Italia un avvenire imperiale. «Sulle rovine dell’impero inglese – diceva l’economista – sorgeranno altri imperi più belli, più utili all’umanità. Se quel giorno gli italiani avranno saputo perfezionare se stessi ad acquistare le energie intime che creano i grandi imperi, essi dovranno ricordarsi che il loro orgoglio maggiore dovrà consistere nel creare un tipo di organizzazione più perfetta e più alta dell’impero inglese. Poiché questo e non il Sacro romano impero e non l’impero germanico moderno e non lo Stato napoleonico francese è il vero erede spirituale e il perfezionatore della più bella creazione politica che il mondo abbia visto: l’impero romano»[16].
Einaudi, in quel periodo, sosteneva la necessità di una oculata scelta di campo, senza pregiudizi e secondo gli interessi dello sviluppo della potenza italiana nel Mediterraneo. In realtà la posizione neutralista, dopo i primi mesi di guerra europea, stava rivelando il suo contenuto di sostanziale isolamento delle strutture italiane dal movimento internazionale delle materie prime e delle risorse finanziarie.
La Germania e l’Austria-Ungheria nel 1913 coprivano il 24% delle nostre importazioni e assorbivano il 22% delle nostre esportazioni, ma l’Europa occidentale e gli Stati Uniti fornivano il 58%, contro il 19% degli imperi centrali, delle materie prime necessarie alla nostra economia.
Ricorda Mario Silvestri che «l’Italia, oltre a molti beni essenziali, che pagava col suo lavoro, doveva importare, per sopravvivere, il 25% del suo fabbisogno di grano e il 95% del fabbisogno di carbone. Il grano non potevano di certo fornirlo gli imperi centrali, stretti alla gola dal blocco dell’Intesa, che comandava le vie del mare. E quanto al carbone, benché in teoria ne fosse possibile l’importazione dalla Germania, in pratica esso non poteva arrivare per via terra»[17].
Tutto questo non poteva non pesare nell’opinione che si veniva formando attraverso la stampa controllata dai gruppi finanziari consapevoli della realtà economico-strategica, specialmente il «Corriere della Sera» di Milano e «Il Secolo XIX» di Genova[18].
Riteniamo tuttavia preponderanti, nella decisione di passare dalla neutralità all’intervento, le considerazioni politiche legate al desiderio di completare l’unità nazionale conseguibile soltanto attraverso la partecipazione al conflitto a fianco dell’Intesa e a seguito della vittoria di questa. Tuttavia per quanto riguarda le opinioni degli ambienti influenti sulle decisioni governative non vanno sottovalutate le considerazioni che andavano facendo gli operatori economici e finanziari di maggior rilievo.
Il problema era, poi, di garantire sufficienti disponibilità finanziarie sia per l’uso pubblico che per quello privato. A tal proposito va tenuto presente che la rendita pubblica all’estero era collocata soprattutto in Francia: una caduta dei corsi avrebbe avuto negative e generali ripercussioni per il credito italiano fuori dei confini. Non di importanza inferiore era la necessità di garantire il rifornimento di combustibili e di minerali (ferro, rame, ecc.) al fine di non interrompere il promettente sviluppo industriale che, oltre alla dispersione di energie e capitali impiegati, avrebbe comportato disoccupazione e quindi disagi e tensioni. E, come già detto, tali rifornimenti venivano per la maggior parte dall’area anglo-franco-americana.
Sul piano economico va anzitutto ricordata la scarsa potenzialità industriale italiana. Invero, specialmente nel precedente decennio, l’Italia aveva fatto considerevoli progressi rispetto al ritardo col quale si era presentata alla competizione con gli altri paesi europei che avevano già compiuto la loro «rivoluzione industriale».
Ma di fronte allo sforzo che stava per richiedere il conflitto e alle capacità produttive degli altri contendenti la situazione italiana non poteva non destare fondate preoccupazioni. In pratica tuttavia vi erano tutte le promesse per un consistente sviluppo e questo era avvertito da quanti anelavano a svolgere quel ruolo che era stato alla base – sia in sede culturale che in sede produttiva – dell’impulso che si voleva dare per far assumere al nostro Paese un ruolo di protagonista.
Comunque la situazione era la seguente: l’Italia aveva una produzione annua di poco più di 900 mila tonnellate di acciaio e di nemmeno 430 mila tonnellate di ghisa. Di contro l’Austria-Ungheria produceva oltre 2 milioni e 600 mila tonnellate di acciaio e più di 2 milioni di tonnellate di ghisa. Naturalmente non è il caso di fare i confronti con la produzione tedesca (17 milioni e mezzo di tonnellate di acciaio e oltre 17 milioni di tonnellate di ghisa) perché quelle cifre devono essere più realisticamente confrontate con la produzione franco-inglese.