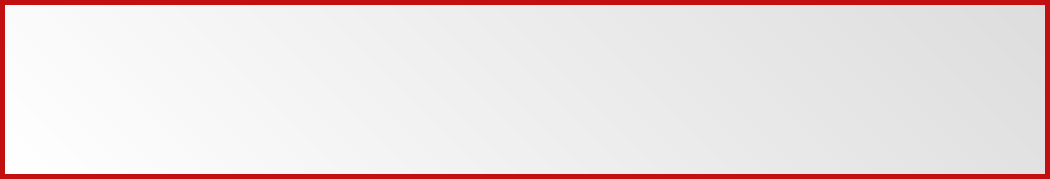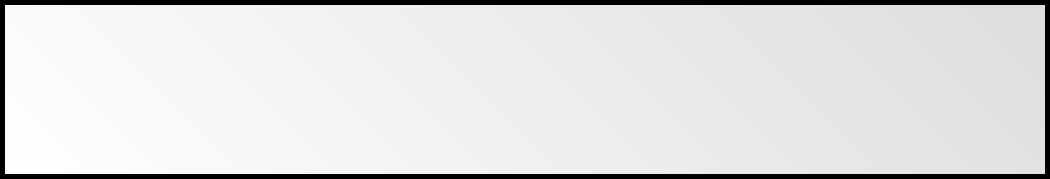Mutamenti strutturali in Italia a seguito Guerra 1915-18
12. La disciplina economico-sociale di guerra.
Un dato interessante per la struttura sociale oltre che economica riguarda l’utilizzazione delle competenze tecniche e organizzative nonché della forza lavoro. Si costruivano nuovi stabilimenti, si istruirono specialisti per le lavorazioni più complesse, si esonerarono dal servizio militare prima i direttori di fabbrica, poi i marittimi e i piloti della marina mercantile. Come abbiamo visto nei momenti delle semine e dei raccolti furono esonerati i contadini.
Ben preso tuttavia il sistema degli esoneri diede luogo a critiche da parte di coloro che erano mandati al fronte e non potevano vantare particolari mestieri collegati con l’industria di guerra o con altre necessità della mobilitazione interna dei rifornimenti. Tra l’altro, oltre ad arrischiare costantemente la vita, coloro che erano presso i reparti combattenti avevano misere paghe, mentre coloro che lavoravano al sicuro nelle attività industriali o collegate avevano buoni salari. La legislazione al riguardo perciò fu cambiata. Fu ridotta la minimo l’esenzione degli appartenenti alle classi più giovani (per i nati dopo il 1892) e furono ricontrollati tutti gli esoneri al fine di mandare al fronte più gente possibile. Inoltre gli esonerati dal servizio militare dovettero pagare una tassa speciale e di converso i combattenti godettero di particolari esenzioni fiscali. A questo riguardo va ricordato che tra le imposte speciali miranti a rendere uniforme l’onere della guerra fu applicata un’imposta progressiva agli stipendi dei direttori amministratori delle società[48] e che pure i salari degli operai ebbero tassazioni progressive in relazione al loro ammontare[49]. Queste imposte dal 1918 al 1924. furono sostituite dalla “contribuzione straordinaria di guerra” che consisteva in un aumento del 25 per cento circa delle imposte complessivamente a carico di coloro che non erano stati sotto le armi o non erano stati presso reparti combattenti per almeno un anno[50].
Fra le conseguenze dei malumori dei combattenti e delle loro famiglie per gli esonerati o i “comandati” nelle industrie lontane dai campi di battaglia, vi fu l’inasprimento della disciplina sui luoghi di lavoro, che comunque si rendeva necessaria anche ai fini dei rendimenti richiesti dallo sforzo bellico. Gli operai esentati o comunque occupati nelle “fabbriche ausiliare”non potevano lasciare il lavoro senza permesso, il che equivaleva alla proibizione di scioperare; inoltre non potevano trasferirsi da un posto all’altro in cerca di un impegno migliore, né erano ammessi atti di insubordinazione o di non-cooperazione. Coloro che si rendevano colpevoli di disordini venivano subito mandati al fronte. La disciplina fu inizialmente affidata agli ufficiali, poi ai Comitati regionali.
Questo rigore consentì di portare l’assenteismo nelle industrie belliche dall’8,4% al 4,9% anche perché gli operai tenevano a conservare sia il posto che lo stipendio. Non soltanto le retribuzioni in queste industrie erano tendenzialmente superiori a quelle delle attività civili, ma le paghe venivano distribuite per il 50% anche quando gli stabilimenti restavano fermi per mancanza di materie prime.
La fissazione delle tariffe retributive era effettuata dai Comitati regionali per la mobilitazione industriale. Non erano ammesse rivendicazioni da parte dei sindacati, ma si poteva ricorrere al Comitato centrale. A questo proposito va ricordato che fu introdotto a questo fine un istituto giuridico che sarà poi ripreso in Italia in diverse condizioni politiche ed economiche: l’arbitrato obbligatorio tra capitale e lavoro. Esso fu applicato con equità e con spirito teso al bene comune; dall’esame della casistica emerge che nella sostanza le ordinanze risultarono più favorevoli al personale che alle direzioni delle imprese[51]. Dalle procedure instaurate e dalle deliberazioni prese derivò un’interessante serie di “principi” che regolamentarono efficacemente tutta la materia e che costituì un interessante precedente operativo, anche perché il 90% delle vertenze furono collettive, che fu accolto dalla giurisprudenza della autorità giudiziaria ordinaria[52].
13. L’avvento dello Stato imprenditore nel pensiero di Pantaleoni, Jannaccone ed Einaudi.
Come abbiamo visto, la politica economica italiana nel periodo 1915-1918 fu interamente assorbita dallo sforzo bellico e, malgrado la generale convinzione che la subordinazione delle attività economiche private alle esigenze dell’organizzazione statale fosse di carattere eccezionale e transitorio, tuttavia le strutture create e i problemi venuti a maturazione o suscitati dalle drammatiche vicende resero irreversibili le concezioni interventiste e le pratiche dirigiste.
Naturalmente l’intervento dello Stato dopo il 1914-15 nell’economia non deve essere considerato come una novità. Oltre a una vasta politica di lavori pubblici, volti a creare quelle che più tardi saranno chiamate «infrastrutture», gli Stati preunitari, in parte, e quello unitario, in misura maggiore, furono interventisti sia direttamente, come nel caso delle «regie cointeressenze», sia favorendo attraverso concessioni amministrative e sovvenzioni l’avvio di attività economiche. Ma il carattere di questo interventismo fu sempre episodico, legato a specifiche e limitate finalità e comunque considerato eccezionale perché contrario alle dominanti impostazioni teoriche.
Comunque, tale interventismo era sempre limitato alle «economie esterne» (per es. i trasporti) da assimilarsi ai servizi forniti istituzionalmente dallo Stato, come la «difesa», l’«ordine pubblico», ecc. mai alle attività manifatturiere, estrattive, e simili, salvo per quelle di interesse militare.
Le concezioni interventistiche e dirigiste nei settori diversi da quelli dei servizi pubblici nacquero proprio con la guerra, a causa di essa, ma anche a seguito delle esperienze e delle maturazioni che con essa giunsero a compimento.
Tali esigenze furono avvertite dai più attenti economisti dell’epoca, i quali, pur esponenti degli indirizzi liberistici, si rendevano conto della necessità di contemperare l’efficienza delle strutture imprenditoriali, gestite privatisticamente, con direttive vincolanti poste dagli organi statali in relazione agli specifici obiettivi.
«Il primo a lanciare quella proposta – scrive il Cianci[53] – fu Maffeo Pantaleoni sul “Giornale d’Italia” del 15 giugno 1915 con un articolo dal titolo allora rivoluzionario: Lo Stato azionista.[54]La guerra [secondo Pantaleoni] rendeva possibile l’attuazione di alcune riforme radicali in materia di amministrazione dello Stato che in periodi di pace non si sarebbero mai potute realizzare».
E in tutti questi casi l’economista proponeva che lo Stato assumesse una partecipazione azionaria in quelle imprese. Egli si riferiva alle industrie (come, per esempio, la Terni e l’Ansaldo) che conveniva sviluppare nel Paese «per ragioni politiche, e in contrasto con il tornaconto economico»; che erano «sottratte alla concorrenza estera»; che per la loro stessa natura non potevano «avere molti concorrenti all’interno»; che contavano, in pratica, un solo cliente nello Stato.
Pantaleoni riteneva per contro che sarebbe stato un grave errore «fare di queste industrie delle aziende di Stato». Quindi che rimanessero a gestione di tipo privatistico ossia delle s.a.(società anonime, quelle che in seguito saranno chiamate società per azioni, s.p.a.), ma partecipate dallo Stato attraverso una sua maggioranza azionaria.
Dunque anche uno dei più rigorosi liberisti, conscio delle nuove necessità espresse, come già si è detto, occasionalmente dalla guerra, ma frutto non contingente delle esigenze dello sviluppo nazionale, usciva dagli schemi rigidamente legati all’iniziativa e alla gestione aziendale solo privata.
Che il fatto non fosse legato esclusivamente alle vicende belliche è confermato dal successivo articolo, di pochi mesi dopo, nel quale la proposta di partecipazione da parte dello Stato veniva estesa da Pantaleoni alle società di navigazione che trasportavano emigrati.
Successivamente sia luigi Einaudi che Pasquale Jannaccone espressero lo stesso indirizzo. Tra la fine del 1916 e la primavera del 1917 si dibatteva il problema dell’industria degli armamenti e di quella siderurgica in particolare, la quale, approfittando delle incalzanti necessità belliche, fissava alti prezzi al di fuori di qualsiasi possibilità di controllo.
Einaudi nel riprendere la proposta di Pantaleoni («Maffeo Pantaleoni, con la sua consueta penetrazione, ha già detto che la società anonima è la forma delle statizzazioni dell’avvenire» si riferiva specificamente all’industria per la guerra, ma dal contesto appare chiaro che il principio era estensibile a tutti gli interventi statali. Il punto essenziale posto in evidenza era «l’opportunità di dare carattere pubblico all’industria della fabbricazione delle armi, del materiale e del naviglio da guerra». Secondo Einaudi gli Stati continuavano «ad abbandonare questa funzione pubblica all’iniziativa privata», mentre si ostinavano «a fare altri mestieri, di assicuratori, banchieri, o negozianti di grano» in cui riuscivano mediocremente.
La «statizzazione delle fabbriche d’armi» non voleva dire «gestione diretta burocratica o gestione a mezzo di una cosiddetta azienda autonoma». Altro era la «statizzazione», altro era «l’applicazione pratica» delle nuove politiche che l’economista proponeva per «il vecchio metodo della regia cointeressata, attuato con la nuova formula della società anonima».
«Per conseguire la gestione pubblica dell’impresa, il governo avrebbe potuto sottoscrivere parte delle azioni ordinarie di nuove società da costituire appositamente, estendendo la sua partecipazione alle azioni privilegiate e all’acquisto di un’aliquota delle obbligazioni da emettere per far fronte agli investimenti»[55].
Da ultimo, in quegli anni, al congresso della Società italiana per il Progresso delle scienze, Pasquale Jannaccone, insieme con Remo Catani, presentò il 4 aprile 1917 a Milano una relazione su «La grande industria siderurgica in Italia»[56] incentrata sulla tesi che la siderurgia italiana era nata «da un calcolo politico-finanziario non già da un calcolo tecnico-economico; dalla congiuntura favorevole di un breve periodo di tempo, non dalla previsione ragionata delle possibilità dl suo sviluppo in futuro».
Per esempio per Jannaccone l’industria siderurgica italiana non aveva avuto origine da un’iniziativa imprenditoriale privata in base a un calcolo di convenienza, ma erta sta il frutto di una speculazione senza un disegno preordinato né finalizzato. Questo giudizio è certamente eccessivo perché l’attrezzatura ferroviaria e navale – elemento essenziale per lo sviluppo dell’economia italiana dopo l’Unità – furono rese possibili soltanto grazie all’intervento pubblico e agli accordi tra lo Stato italiano e il capitale straniero. Senza queste iniziative pubbliche tali realizzazioni non sarebbero state possibili a causa dell’assenza in Italia di capitali adeguati e di imprenditori privati disposti e, forse, in grado di procedere in questa direzione.
Tuttavia l’economista napoletano aveva ragione, sia per gli inconvenienti derivanti dal clientelismo e dalle possibili corruzioni, sia per quanto si riferiva alle evoluzioni successive della siderurgia italiana e, a tal proposito, condannava l’assurdo sistema dei dazi in vigore i quali, nell’intento di proteggere le diverse fasi delle lavorazioni, finivano per ridurre i consumi e quindi l’espansione del settore.
Per contrastare questo stato di cose pure Pasquale Jannaccone avanzava la proposta che lo Stato promuovesse una «grande industria siderurgica» comprendente miniere, energia idroelettrica, ferrovie, ecc., ossia un sistema che andasse dalla materia prima ai prodotti finiti. La presenza dello Stato avrebbe assunto la figura dell’azionista (regolando direttamente la produzione solo per ciò che avesse interessato gli armamenti e lasciando il resto della produzione e della distribuzione alle regole del libero mercato).
Pur nell’abbozzo della proposta, la «grande industria siderurgica nazionale» indicata da Jannaccone si configura come quel settore organizzato per cicli «dalla materia prima al prodotto finito» che sarà alla base della riforma corporativa degli anni ’30, rimasta però in parte sulla carta per la mancata introduzione della programmazione guidata dallo Stato e gestita dalle categorie. L’Iri, infatti, nato appunto negli anni ’30, realizzerà l’economia mista dello Stato azionista, ma non l’economia programmata corporativa. Né il Consiglio nazionale delle corporazioni, né il Comitato corporativo centrale furono convocati per discutere l’istituzione dell’Iri. Gli economisti corporativi (Arias, Arena, F. Carli, Gangemi, ecc.) considerarono l’Iri come uno strumento di emergenza e quindi a-corporativo[57].
Nota Cianci che lo scopo dello Jannaccone era nobile ma che inadeguati erano i mezzi (le miniere italiane e le forze idrauliche) e troppi le incrostazioni legislative e i privilegi da smantellare. A nostro avviso, oltre a questo aspetto mancava in realtà quella maturazione concettuale e strutturale che solo successivamente sarebbe stata espressa ma che non sarà attuata.
Il passaggio dall’economia dell’imprenditorialità disorganizzata all’economia programmata, degli imprenditori organizzati per grandi cicli produttivi, non avrà luogo. Successivamente si passerà solo allo Stato-imprenditore, metà liberista e metà socialista, dei primi anni del Secondo dopoguerra.
Il resto è quanto constatiamo: il progressivo deperimento dell’economia italiana e l’assenza di una vera e moderna economia organizzata e finalizzata.