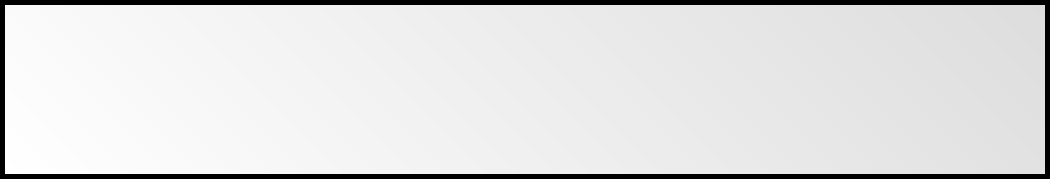Spengler, il falso pessimista che stimava Mussolini ma non amava il nazismo
Spengler, il falso pessimista che stimava
Mussolini ma non amava il nazismo
Articolo de “La Verità” sul libro di Alain de Benoist
“Quattro figure della Rivoluzione Conservatrice tedesca”
venerdì 11 novembre 2016
Nel 1925, André Fauconnet poteva scrivere: «Dalla fine della guerra mondiale, nessuna opera filosofica ha avuto, nell’Europa centrale, una risonanza paragonabile a quella di Spengler». Il discorso è appena esagerato. La pubblicazione del primo volume del Tramonto dell’Occidente, nell’aprile 1918, alcuni mesi prima della fine della prima guerra mondiale, fece l’effetto di un fulmine a ciel sereno. L’eco incontrato in Germania, in particolare, fu fenomenale, come testimonia il numero di libri e opuscoli pubblicati a loro volta per rispondergli, commentarlo, incensarlo o criticarlo. Una delle ragioni di questo successo, come osservò Ernst Cassirer, fu incontestabilmente il titolo del libro, ispirato a Spengler da un’opera di Otto Seeck pubblicata alla fine del XIX secolo.
Violentemente criticato da Heinrich Rickert e Otto Neurath, trattato da «triviale carogna» (triviale Sauhund) da Walter Benjamin e da «Karl May della filosofia» da Kurt Tucholsky, Spengler fu al contrario salutato da Georg Simmel, cui aveva inviato una copia del suo libro, come l’autore della «filosofia della storia più importante dopo Hegel», il che non era un piccolo complimento. L’opera produsse grande impressione anche su Ludwig Wittgenstein il quale approvava il pessimismo di Spengler, come pure le grandi linee del suo metodo, sull’economista Werner Sombart, cosi come sullo storico Eduard Meyer che, dopo una discussione di cinque ore con l’autore del Tramonto dell’Occidente, divenne suo ammiratore e amico. Max Weber fu meno impressionato, ma invitò comunque Spengler a prendere la parola nel quadro della sua settimana di sociologia all’Università di Monaco nel dicembre 1919. Quanto a Heidegger, che cita spesso Spengler pur non avendogli mai dedicato uno studio esaustivo, pronunciò nell’aprile del 1920, a Wiesbaden, una conferenza su Il tramonto dell’Occidente.
L’idea centrale dell’opera, che si inscrive al contempo nella tradizione della Kukturkritiktedesca e in quella del «pessimismo culturale», è che l’umanità non abbia un obiettivo prestabilito, un’idea direttrice, un piano organizzativo più di quanto non ce l’abbiano «le orchidee o le farfalle». L’umanità è «o un concetto zoologico o un vuoto nome» (…). Non c’è dunque una «storia dell’umanità» nel senso di un processo omogeneo. Ci sono solo storie separate corrispondenti alle diverse culture, il cui sviluppo e declino obbediscono alle stesse leggi. «Per lui», come scrive Lucian Blaga, «una cultura è un organismo reale, dotato di un’“anima” specifica, la quale si distingue radicalmente dall’anima individuale di ciascuno degli uomini che costituiscono la collettività».
In una celebre pagina del Tramonto dell’Occidente, Spengler si paragona a Copernico. Come quest’ultimo aveva fatto abbandonare la posizione geocentrica a favore dell’eliocentrismo, egli si propone di abbandonare l’europeocentrismo che ha predominato fino a quel momento. Egli distingue dunque otto grandi culture umane, tra le quali la cultura araba (o «magica»), di cui rivendica la scoperta. L’anima dell’Antichità greca è definita «apollinea», quella della cultura occidentale «faustiana». L’anima faustiana ha come simbolo lo spazio tridimensionale infinito; l’anima apollinea, il corpo isolato (lo spazio limitato); la cultura russa, la pianura senza limiti; la cultura cinese, il cammino nella natura e la cultura araba, lo spazio-volta.
Paul Valéry dichiarava nel 1919: «Ora noi civiltà sappiamo di essere mortali». Spengler afferma con forza la stessa cosa. Respingendo la convenzionale divisione Antichità-Medioevo-Modernità, egli distingue tre grandi periodi della vita delle culture, corrispondenti alla nascita, allo sviluppo storico e alla vecchiaia seguita dalla morte. Come le piante o le specie animali, le grandi culture dispongono dunque di una morfologia che va di pari passo con uno sviluppo interno che percorre sempre le stesse tappe: nascita, maturità, vecchiaia e morte. La ripetizione di questi stili non ha niente a che vedere con l’Eterno Ritorno di cui parla Nietzsche, ma è piuttosto un memento finis che va nel senso di una ineluttabile immanenza della fine: «Vi è una giovinezza e una senilità nelle civiltà, nei popoli, nelle lingue, nelle verità, negli dèi, nei paesaggi – come vi sono querce e pini, fiori, rami e foglie, giovani e vecchi […]. Ogni civiltà ha le proprie, originali possibilità di espressione che germinano, si maturano, declinano e poi irrimediabilmente scompaiono»
COSA SONO LE NAZIONI
Le culture esistono nel loro grado più alto quando l’anima che le porta conferisce loro (e diventa essa stessa) una forma. Una nazione si definisce come un popolo portato dallo stile di una cultura.
«Una civiltà muore quando la sua anima ha realizzato la somma delle sue possibilità», scrive Spengler, proponendo così una visione entelechica della storia [nella filosofia di Aristotele, l’entelechia è una realtà che ha raggiunto il pieno grado del suo sviluppo]. Ogni vera tradizione reca in sé la propria fine: l’immanenza della fine è la condizione sine qua non della storia. è anche il fondamento della concezione tragica della vita. Quando la tradizione e l’«anima» perdono la loro potenza, suona l’ora della civilizzazione, che è anche quella del declino. Nella civilizzazione, la vita sociale si concentra nelle grandi città, in seno alle quali le folle anonime non hanno più alcuna possibilità di «essere-in-forma». Il cittadino sradicato dell’epoca delle città mondiali si definisce come un nuovo nomade […]
Un altro tratto delle civilizzazioni morenti è che hanno, appunto, anzitutto paura della morte: «Meglio morire che essere schiavi, dicono i vecchi contadini frisoni. Rovesciate questo aforisma e avrete la formula di tutte le civilizzazioni tardive». Il passaggio dallo stadio della civiltà a quello della civilizzazione ha avuto luogo nel IV secolo per il mondo greco-latino, nel XIX secolo per la cultura occidentale. L’Europa inizia infatti il suo tramonto nel momento stesso in cui l’ideologia del progresso e le filosofie ottimistiche (Comte, Spencer, Marx) sono al culmine. In Occidente, la civilizzazione si identifica sociologicamente con il dominio della borghesia, politicamente con la vittoria del parlamentarismo e dei partiti, economicamente con il predominio del denaro. Il «tramonto dell’Occidente» coincide con quella che Walter Rathenau definiva «meccanizzazione del mondo» e Kurt Breyzig «meccanizzazione dell’anima». Viene allora l’epoca del «cesarismo» – esemplificata tanto da Lenin quanto da Mussolini – che è anche quella dell’imperialismo, del materialismo, della supremazia della tecnica, della tecnocrazia, delle manipolazioni ad opera della stampa. L’Occidente estende il suo dominio nel mondo intero, ma non esporta più la sua civiltà, bensì la sua civilizzazione. […]
IMMAGINE ERRATA
Resta il fatto che l’immagine del «tramonto dell’Occidente» ha continuato a essere utilizzata per alimentare il rimprovero fatto a Spengler di sostenere una dottrina colma di «fatalismo» e, soprattutto, di «pessimismo». Questo rimprovero è fondato? Spengler vuole essere in effetti anzitutto un «realista», e il pessimismo cui si richiama è cosa del tutto diversa dal «pessimismo vile delle stanche animucce, che temono la vita e non sopportano la visione della realtà». Su questo punto, si è lungamente intrattenuto in un testo pubblicato nel 1921, poco prima dell’uscita – il 20 maggio 1922 – del secondo volume del Tramonto dell’Occidente.
Spengler respinge subito l’accusa di pessimismo, «ingiuria con cui gli eterni vegliardi perseguono ogni pensiero destinato ai pionieri di domani». Dirà, certo, che l’ottimismo non è altro che una pigra viltà che non ci si deve attendere una redenzione, né una speranza da coltivare: soltanto i sognatori credono che esista una via d’uscita. Ma un vero pessimismo implicherebbe che non ci siano più obiettivi da raggiungere. Spengler pensa, al contrario, che l’uomo occidentale ne abbia ancora così tanti che è piuttosto il tempo a rischiare di mancargli. Anche se corrisponde alla stadio finale della nostra civiltà, la fase che viviamo oggi resta grandiosa: è «quella che il mondo antico ha conosciuto nell’intervallo tra Canne e Azio». Non c’è dunque ragione di disperare. Bisogna soltanto che ci sia sintonia tra gli sforzi che si dispiegano, gli obiettivi che ci si prefigge e le possibilità celate nel momento storico che si vive. Probabilmente, le possibilità architettoniche dell’Europa sono esaurite. Non avremo più un Goethe, uno Shakespeare, un Botticelli, un Wagner. Ma avremo nuovi Cesari, così come aveva predetto un autore francese misconosciuto del XIX secolo. Quale sarà il loro ruolo? Sarà anzitutto di mettere termine alla politica partigiana, e di farla finita nello stesso tempo con la «dittatura del denaro»: «La spada sconfiggerà il denaro, la volontà del signore assoggetterà di nuovo la volontà del pirata». Il che implica che si debba rifare della politica un rapporto di forze: «Una potenza non può essere distrutta che da un’altra potenza, non da un principio, e non ce n’è un’altra contro il denaro».
Spengler non raccomanda dunque affatto la rinuncia, l’ascesi negativa davanti all’ineluttabile kali-yuga. Non si accontenta nemmeno, come Evola, di voler «cavalcare la tigre». Non professa la disperazione romantica di un Gobineau. Essere «pessimista» con il pretesto che la nostra cultura si avvicina alla fine equivale a non voler più vivere con il pretesto che un giorno moriremo. Spengler sottolinea inoltre che se c’è un determinismo globale che pesa sulla cultura, non c’è un determinismo individuale. L’uomo ha sempre la possibilità di restare fedele all’idea che si fa di se stesso. Un «partito preso vitale» è sempre possibile. È ciò che Spengler chiamerà la «scelta di Achille»: «Meglio una vita breve, piena d’azione e gloria, piuttosto che un’esistenza prolungata, ma vuota» […]
GUARDARE AVANTI
Bisogna qui evidentemente citare le pagine finali de L’uomo e la tecnica: «Dobbiamo proseguire con coraggio, fino al termine fatale, la strada che ci è tracciata. Non c’è alternativa. Il nostro dovere è di radicarci in questa posizione insostenibile, senza speranza, senza possibilità di sostegno. Stare in piedi, stare in piedi, sull’esempio di quel soldato romano il cui scheletro è stato ritrovato davanti a una porta di Pompei e che, durante l’eruzione del Vesuvio, morì al suo posto perché nessuno era andato a dargli il cambio. Ecco la nobiltà. Ecco la grandezza. Una fine onorevole è l’unica cosa di cui un uomo non può essere defraudato». In definitiva, l’etica avrà l’ultima parola: «Chi è degno di qualcosa finirà col trionfare». Perfino nella sua apparente rigidità, il sistema spengleriano è dunque, almeno per le anime forti, un rimedio al pessimismo […].
Il memento finis che è alla base della filosofia della storia di Spengler costituisce anche il fondamento di un’etica eroica – nella misura stessa in cui nessun progetto può oltrepassare i limiti assegnati dalla storia.
Allo stesso modo, quando raccomanda il «prussianesimo», è anzitutto a uno stile che Spengler si riferisce – l’etica del dovere, a base di impersonalità attiva e di senso dell’onore – e non a un’appartenenza storica o a un luogo di nascita. È ugualmente in questo senso che oppone il «socialismo etico», di carattere «romano-prussiano», al «socialismo economico», ossia al marxismo, che non è altro che un «capitalismo dal basso».
Il «socialismo prussiano» cui egli si richiama è un socialismo dei doveri, non delle rivendicazioni. Non è tanto una dottrina economica quanto uno stile di vita fondato anzitutto sul servizio e il contegno, lo stile impersonale e lo spirito comunitario. Per gli individui come per i popoli, si tratta di «mettersi in forma» per mezzo di un principio. Ora, la libertà interiore la si attinge solo nella disciplina e nel servizio: «Questa è la nostra libertà: essa ci affranca dal giogo dell’individualismo e dalla sua economia arbitraria». Il socialismo prussiano deve essere portato dalla volontà di potenza dell’anima faustiana che cerca di mettere in forma la massa per darle uno stile. La Prussia è dunque per Spengler un «mito» ideologico ancor più che una realtà storica: ci sono «prussiani» ovunque. Su questa base, Spengler denuncia il liberalismo («l’Inghilterra interiore») e il capitalismo («il dominio del denaro»): «Ognuno per sé: questo è inglese; ciascuno per tutti: questo è prussiano» […].
Stabilitosi a Monaco a partire dal 1911, Spengler ebbe tutto il tempo di seguire la nascita e lo sviluppo del movimento nazionalsocialista. L’ostilità che gli manifestò sembra non essersi mai smentita. Dopo il putsch della Feldherrnhalle del novembre 1923, scrive a Elisabeth Förster-Nietzsche: «È un peccato per la giovane generazione essere caduta nelle mani di capi, di sciocchi, di arrivisti e peggio ancora, così inferiori!». In Neubau des Deutschen Reiches (1924), denuncia l’antisemitismo, come pure le «utopie e le tesi economiche infantili» dei Völkische, descritti come sognatori, eccitati che ragionano a colpi di slogans e idee romantiche senza capire che cos’è la politica, paragonandoli sin dalla prima pagina alla «gioventù dorata» della Rivoluzione francese. Lo stesso anno, rivolgendosi il 26 febbraio 1924 – il giorno stesso in cui inizia a Monaco il processo a Hitler – agli studenti di Würzburg membri dello Hochschulring Deutscher Art, dichiara che il popolo ha bisogno di un «vero eroe», non di un «eroe da operetta», mette in guardia i suoi ascoltatori contro un movimento politico in cui il lavoro intellettuale è stato sostituito dalle marce e dai cortei, poi conclude che «i trombettieri diventano raramente generali».
Il 15 marzo 1927, scrive al germanista francese André Fauconnet (1881-1965), professore a Poitiers, uno dei primi autori a interessarsi a lui in Francia: «Sono del parere che la politica debba fondarsi sulla realtà e su un ragionamento lucido e non su sentimenti romantici […]. Non soltanto mi sono tenuto lontano dal movimento nazionalsocialista che ha guidato il putsch di Monaco, ma in quel momento ho fatto anche tutto il possibile, purtroppo invano, per impedirlo» […]. Sul piano delle idee, ciò che Spengler rimprovera al nazionalsocialismo è anzitutto di veicolare un’ideologia razzista. Il tramonto dell’Occidente, mettendo l’accento sul relativismo culturale, l’identità di struttura e l’incommensurabilità delle culture, aveva già scalzato le basi dell’etnocentrismo che è all’origine di questa dottrina. Nel secondo volume (1922), Spengler polemizza contro la «teoria razziale», descritta come un semplice materialismo e di cui coglie bene ciò che ha di antipolitico e soprattutto di antistorico. Spengler nega l’idea di una continuità biologica o razziale e afferma che non c’è mai stato un ideale di «purezza razziale», che questo ideale non è altro che un’invenzione delle folle eterogenee delle grandi città. Respinge la tesi di un meticciato corruttore, quella della superiorità assoluta di una razza particolare, quella di un legame esistente tra la «purezza razziale» e il valore delle realizzazioni culturali. L’insistenza con la quale i dirigenti della NSDAP sfruttano la nozione di razza li pone, ai suoi occhi, tra gli «handicappati razziali» […].
«L’unità della razza», si leggerà in Anni decisivi, «è una frase grottesca […]. Chi parla troppo di razza, dimostra in tal modo di non averne più. L’importante non è la razza pura, ma la razza forte che un popolo possiede in sé». Allo stesso modo, per Spengler l’antisemitismo nasce dal risentimento e dall’invidia. Gli antisemiti, dirà, sono per l’appunto le persone che manifestano più frequentemente i tratti che attribuiscono agli ebrei. Quanto a lui, relativamente agli ebrei, raccomanda l’assimilazione. […]
NOBILTÀ SPIRITUALE
In definitiva, per Spengler, la «razza» è un fenomeno puramente spirituale che segna una qualità del carattere, legata alla forma che si è acquisita, e dunque non ha niente a che vedere con la razza della medicina veterinaria dei teorici nazisti. La «razza» è un’anima che si realizza nella storia, uno stile, un modo d’essere, un atteggiamento davanti alla vita. Non ci sono razze superiori o inferiori, ma elementi superiori e inferiori in tutte le razze. Spengler oppone continuamente la «razza» che si possiede a quella cui si appartiene: «Una è l’etica, l’altra la zoologia». «Avere razza» significa comportarsi come il legionario romano le cui ossa sono state ritrovate davanti a una porta di Pompei e che morì in piedi perché, «in occasione dell’eruzione del Vesuvio, ci si era dimenticati di dargli il cambio», come si legge nelle ultime righe de L’uomo e la tecnica. In altri termini, «avere razza» vuol dire avere valore – appartenere a un’aristocrazia («Rasse ist Auslese»). Per questo, l’obiettivo che il nazionalsocialismo si è fissato, e cioè fare dell’intera Germania una «nazione di aristocratici», appare a Spengler grottesco: nessuna massa può essere aristocratica, è una contraddizione in termini59.
È comprensibile che i Völkische, ossessionati dalla «razza» e dal «sangue», non abbiano apprezzato. D’altronde, avevano criticato Spengler sin dall’epoca di Weimar. Nel 1922, nella prefazione alla nuova edizione de La genesi del XIX secolo, Houston Stewart Chamberlain denuncia apertamente le idee del Tramonto dell’Occidente in nome del «pensiero razziale», il che gli consentirà di essere considerato nei circoli völkisch come un «anti-Spengler». Tre anni più tardi, nel 1925, Alfred Rosenberg rimprovera a Spengler di essersi energicamente pronunciato contro il «pensiero völkisch» e di non aver colto l’importanza della «questione ebraica» […].
In occasione dei cinquanta anni di Spengler, mette di nuovo in guardia contro di lui: «Oswald Spengler non è un “maestro” di cui dovremmo seguire “pienamente e interamente” gli insegnamenti, come hanno potuto affermare alcune teste vuote. Al contrario, malgrado l’esattezza di un certo numero di sue critiche, egli appartiene al passato, un passato senza volontà». Sembra che lo stesso Hitler abbia manifestato, sin dal 1929, la sua ostilità alle tesi di Spengler, almeno a detta di alcuni della sua cerchia come Otto Wagener.
Spengler denuncia anche nel nazionalsocialismo una nuova forma di «imperialismo di massa». Sappiamo che questo temine ha in lui un senso particolare: «La massa è l’informe assoluto che perseguita con il suo odio ogni specie di forma» (Il tramonto dell’Occidente). Incarnazione sociologica del nomadismo, la massa, essendo informe, è per natura antistorica. Ora, dice Spengler, il nazionalsocialismo concepisce essenzialmente la nazione come massa. Lungi dall’essere un nuovo Cesare, Hitler è solo il capo di un partito la cui legittimità viene «dal basso». È un «plebeo» nel senso che Donoso Cortés dà a questo termine, ossia un uomo che, invece di guidare le masse, si lascia guidare da esse, si fonda su di esse e sostituisce l’azione politica con una orchestrazione dell’entusiasmo. […] Contrariamente a Mussolini, per il quale prova ammirazione, Hitler, ai suoi occhi, non è un uomo di Stato-nato, ma soltanto un agitatore-nato. Il che equivale a dire che il nazionalsocialismo è destinato a fallire in quanto regime, esattamente per le stesse ragioni che gli hanno fatto avere successo in quanto movimento. […]
SVASTICHE AL POTERE
Hitler arriva al potere il 30 gennaio 1933. Quindici giorni più tardi, Spengler scrive al magnate della stampa Albert Knittel, presidente dell’Associazione degli editori di giornali tedeschi: «L’attuale ministero di carnevale ha dovuto infine darle, come a milioni di altri, una giusta opinione di H[itler] e H[ugenberg]». Il 5 marzo, dopo il nuovo successo elettorale della NSDAP, successivo all’incendio del Reichstag, esclama: «Adesso vedremo se Hitler è qualcosa di diverso da un trombettiere!».
Il nuovo regime cerca allora, beninteso, di conciliarsi un certo numero di personalità conosciute e riconosciute. Per questo, probabilmente, il 17 marzo 1933 Goebbels invia un telegramma a Spengler proponendogli di intervenire alla radio alla vigilia del Giorno di Potsdam (il 21), durante il quale Hindenburg consegnerà i poteri nelle mani di Hitler. Spengler rifiuta. […]
Nel luglio 1933, Spengler si trova a Bayreuth, dove assiste come tutti gli anni al Wagner festival. Il 26 spedisce a sua sorella un biglietto così concepito: «Rappresentazioni magnifiche. Ho avuto ieri una lunga conversazione con Gustav. Ritorno a Monaco sabato». «Gustav» è Hitler! Il colloquio che, contrariamente a quanto scrive Gilbert Merlio, non è stato sollecitato da Spengler, ma organizzato da Else Knittel, moglie di Albert Knittel e grande amica della famiglia Wagner, è durato un’ora e mezza, esattamente dalle 12,30 alle 14. Possediamo a questo proposito diverse testimonianze, a cominciare da quella della sorella di Spengler, secondo la quale la conversazione avrebbe riguardato la politica francese e le correnti esistenti all’interno della Chiesa evangelica. Spengler, in quella occasione, le avrebbe descritto Hitler in questi termini: «Un uomo affidabile, ma quando si è seduti di fronte a lui, non si ha nemmeno una volta l’impressione che abbia una qualche importanza».